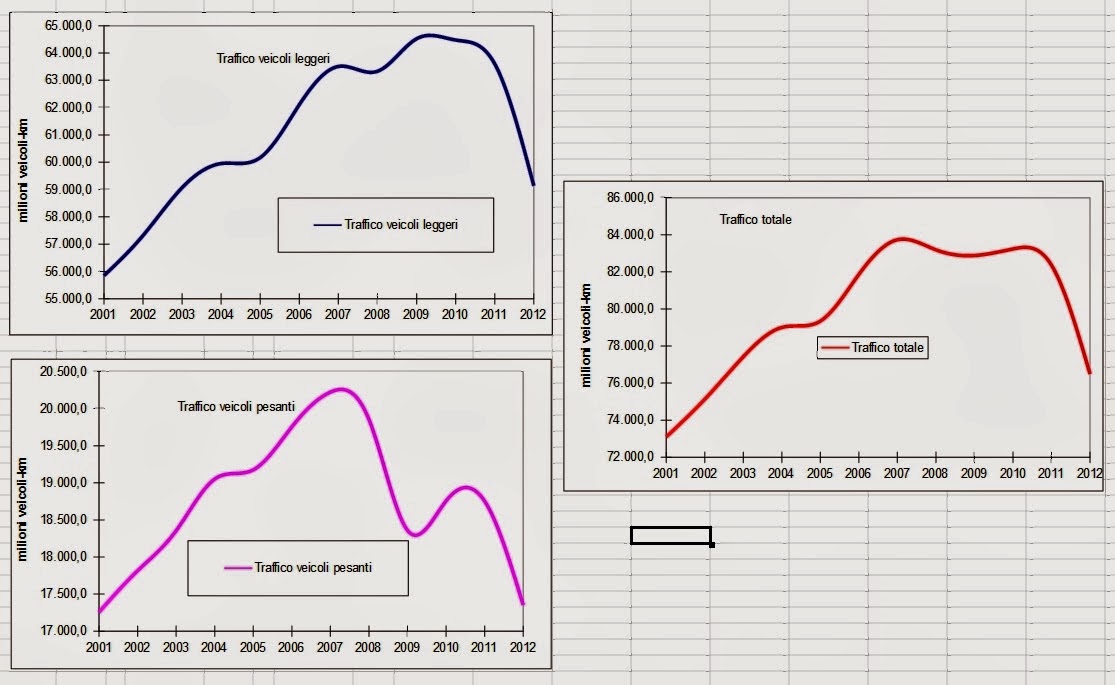Da “The frog that jumped out”. Traduzione di MR
Di Ugo Bardi
Il blog della rana che saltò via è apparso on line poco meno di un anno fa. Col nuovo anno, ho pensato che un mio piccolo sproloquio potesse starci. L’ho iniziato elencando tutto ciò che abbiamo fatto di sbagliato nella comunicazione del problema climatico ma, andando avanti, ho scoperto che c’erano anche altre cose positive che avrei potuto dire. Così, il risultato finale è qualcosa che cerca di suggerire una qualche strategia positiva per la comunicazione sulla base della teoria dei network e di qualche altra osservazione. Probabilmente, questo testo vuole dire troppe cose in troppo poco spazio ma, ora che l’ho scritto, forse troverete un momento per darci un’occhiata e dirmi che cosa ne pensate.
Forse avete avuto anche voi uno di quegli incubi dove venite inseguiti da un mostro. Cercate disperatamente di scappare, ma scoprite che i vostri piedi sono incollati al terreno. Col cambiamento climatico avviene qualcosa di simile. Quasi sentite il respiro del mostro climatico sul collo, ma non vi potete muovere. Niente di muove. Qualsiasi cosa proviamo per convincere le persone del pericolo che ci aspetta non ha nessun effetto. Non attacca.
Ma perché ci troviamo in questa situazione? Dopo tutto abbiamo una tesi forte: abbiamo i dati, abbiamo i modelli, la comunità scientifica è compatta dietro all’idea del cambiamento climatico antropogenico e su cosa si deve fare per fermarlo. Così, abbiamo enunciato la nostra tesi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per spiegare come stanno le cose. Poi, ci aspettavamo che qualcuno facesse qualcosa. Ma no, non è successo niente, non succede niente.
Abbiamo raddoppiato i nostri sforzi. Abbiamo letto il libro “Non fare quello scienziato” (“Don’t be such a scientist”). Abbiamo aperto blog, abbiamo scritto su facebook e twitter, abbiamo rilasciato interviste. Abbiamo cercato di essere chiari, piacevoli, divertenti, abbiamo cercato di portare soluzioni, non problemi. Abbiamo cercato di seguire l’avvertimento che dice “più di tutto, non spaventare nessuno!” Ma non ha funzionato e ormai non funzionerà. Ci siamo ridotti ad aspettare il prossimo disastro ambientale perché finalmente la gente si svegli dal torpore. Ma abbiamo avuto già disastri ambientali a sufficienza e nessuno se ci fa caso. Quindi, siamo destinati a perdere questa battaglia? Di seguito alcuni miei pensieri su questo argomento.
1. Allora, cosa abbiamo sbagliato?
Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato; abbiamo cantato un lamento e voi non avete pianto. Matteo 11:17
Questo blog, “La rana che saltò via”, mi è stato utile per focalizzarmi sul problema della comunicazione della scienza del clima. Credo quindi di avere una qualche idea su cosa esattamente abbiamo sbagliato e la risposta può essere probabilmente trovata in un misto di psicologia umana e nel campo scientifico chiamato “Teoria dei network”. Ha a che fare con la tendenza umana a formare tribù, strutture che nella teoria della rete vengono chiamate “piccoli mondi” (“small worlds”). Potete vedere la struttura di una rete di piccoli mondi nell’immagine – è strutturata come gruppi di nodi fortemente collegati fra loro all’interno del gruppo ma debolmente collegati con l’esterno (immagine da “researchtoaction”)
Che la rete sia strutturata in questo modo è una cosa provata. Che questa sia una proprietà non solo del Web è una cosa chiaramente visibile a tutti. Il mondo sociale intorno a noi è una rete di piccoli mondi – alcuni politici, alcuni religiosi, alcuni culturali, alcuni sportivi, alcuni formati semplicemente da amici e molti altri. Funziona in questo modo; dopotutto siamo una specie tribale: ognuno di noi è integrato in almeno un piccolo mondo. Si può appartenere anche a diversi piccoli mondi su piani” diversi della propria esistenza; diciamo, uno per la propria rete professionale, uno per la propria attività politica, uno per i propri hobby ed altro ancora. Quindi, se la società è costruita come una rete di piccoli mondi, significa che gran parte della comunicazione in atto avviene all’interno di piccoli mondi. Non che non ci siano contatti fra piccoli mondi, ma sono meno numerosi e più deboli.
Il punto è che l’unità di informazione delle informazioni e della loro diffusione in ambito sociale è la tribù, non l’individuo. Questi piccoli mondi/tribù sono tremendamente resilienti. Formalmente non sono esclusivi, non serve un distintivo o un ID per appartenere alla propria rete tribale. Ciononostante è chiaro se si appartiene o no ad essa. Se vi si appartiene, bisogna conoscere il retroterra, le idee formalmente ed informalmente accettate, bisogna conoscere il gergo ed usarlo in modo appropriato. Questo gruppo di idee comunemente accettate rende il gruppo resistente al cambiamento.
Questa forse è una semplificazione eccessiva, ma ho avuto modo di interagire con tribù particolarmente strane, come quella delle “scie chimiche”, cioè coloro che credono e sostengono che i governi del mondo stiano collaborando per avvelenarci diffondendo veleni nel cielo e facendolo sotto forma di scie bianche facilmente rilevabili (“scie chimiche”) lasciate da aerei. Ora, come è possibile che qualcuno creda per davvero in una cosa del genere? E tuttavia, l’identificazione tribale dei credenti è così forte che formano una comunità strettamente legata che reagisce aggressivamente ad ogni tentativo di far ragionare i suoi membri sull’assurdità delle loro convinzioni (non mi credete? Provate voi stessi e mi saprete dire).
Vedete quel meccanismo di identificazione in atto nei commenti dei blog che promuovono l’idea delle scie chimiche – è una specie di coro. Se si commenta senza suonare la canzone giusta si viene attaccati aggressivamente. Il tutto ha un sapore primordiale, qualcosa che ricorda il comportamento di creature che corrono in in branco e ululano alla luna piena.
L’esempio delle scie chimiche è estremo, ma illustra il meccanismo. Si può osservare lo stesso fenomeno, per esempio, nei commenti dei blog dell’anti-scienza come “Watts Up with That?” tenuto da Anthony Watts. Vedete come i membri della tribù di Watts rafforzano le rispettive convinzioni usando un linguaggio e temi simili. Per esserne membri bisogna ripetere i meme comunemente accettati (“non c’è stato riscaldamento durante gli ultimi 15 anni”) ed attaccare gli scienziati del clima (“Michael Mann è un nemico dell’umanità”). La resistenza delle tribù alle nuove informazioni è davvero sorprendente.
Il problema è che non c’è quasi modo di spezzare il sistema di credenze di una piccola tribù dall’esterno. Puntare agli individui non funziona: quella persona confronterà semplicemente le vostre dichiarazioni a quelle della propria tribù e concluderà che le vostre non hanno peso. Si potrebbe dire, “ma questo è ciò che dice la scienza” e la probabile risposta sarà “chi se ne frega?” Se si insiste, la reazione potrebbe essere aggressiva (“gli scienziati hanno tradito il pubblico per ottenere grassi contribuiti per la ricerca”). Nemmeno i più grandi disastri collegati al clima, da Katrina ad Haiyan, possono spostare la tribù dai propri amati sentimenti.
Naturalmente, la struttura del Web è sfumata e complessa e solo una minoranza di piccoli mondi sono ostili alla scienza. La maggior parte sono semplicemente indifferenti e non attueranno, di per sé, una forte contro reazione al meme del cambiamento climatico. Ripetere i concetti climatici in continuazione creerebbe probabilmente un punto d’appoggio in questi mondi neutri. Il problema è che il tentativo viene contrastato da una pari e opposta attività da parte dei piccoli mondi ostili. Questi sono stati efficaci nel posizionarsi come opinione legittima. Lo hanno ottenuto essendo molto attivi e visibili sul Web. Una delle loro armi è quella di ‘trollare’ con commenti aggressivi nei siti scientifici. Pochi troll anti-scienza possono dirottare completamente qualsiasi discussione scientifica e trasformarla in una rissa. Il problema è che è stato scoperto che l’opinione di persone inizialmente neutrali può essere fortemente influenzata da commenti anti-scientifici negativi.
E’ qui che abbiamo fatto il nostro errore cruciale come promotori dell’idea che dobbiamo fare qualcosa per fermare il cambiamento climatico. Tendiamo ad avere a che fare coi troll anti-scienza come se fossero persone che volessero onestamente saperne di scienza. Possono mascherarsi in quel modo, inizialmente, ma il loro scopo è diverso: vogliono dirottare il dibattito e trasformarlo in una rissa. Sanno bene che questa è una tattica molto efficace e che siamo caduti in trappola di continuo – cimentandoci in battaglie inutili che sono servite soltanto a dare visibilità a persone che non la meritavano. Il risultato finale è lo stallo che stiamo osservando ora. Non stiamo riuscendo ad avere un impatto sulla maggioranza delle persone e, di conseguenza, non viene fatto nulla per il cambiamento climatico. Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato; abbiamo cantato un lamento e voi non avete pianto.
2. Il modo per fare meglio
Se conosci il nemico e conosci te stesso, non hai bisogno di temere il risultato di centinaia di battaglie. (Sun Tzu)
Se guardiamo ai dibattiti passati, vediamo che c’è una strategia vincente per la scienza. E’ quella di isolare le tribù anti-scienza e rendere chiaro che sono aree di minoranza le cui opinioni sono condivise da persone che non hanno nessuna credenziale scientifica. Pensate alla battaglia intorno agli effetti sulla salute del fumo, o a quella sulle cinture di sicurezza sulle automobili, o sulla guida in stato d’ebbrezza. Questi concetti avevano degli oppositori, ma le battaglie sono state vinte isolandoli e rendendo chiaro che le loro opinioni (per esempio che non c’è pericolo a guidare da ubriachi o senza cinture di sicurezza) sono opinioni marginali e pericolose che non hanno nessuna base scientifica e non dovrebbero avere lo stesso spazio nel dibattito sulla guida sicura. Solo in questo modo è stato possibile ottenere leggi efficaci sulle cinture di sicurezza e per fermare la guida in stato d’ebbrezza. Molte persone non sono state particolarmente felici di questo, ma hanno accettato l’opinione comune.
Così, il nostro obbiettivo nel dibattito climatico è chiaro: dobbiamo isolare le tribù anti-scienza e rendere chiaro che le loro posizioni sul clima, per esempio che non c’è pericolo da parte del riscaldamento globale, sono opinioni marginali senza alcuna base scientifica. Inoltre, queste opinioni sono pericolose e non dovrebbero avere “pari spazio” nel dibattito su come mantenere il clima terrestre sicuro per gli esseri umani. Se possiamo ottenere questo, allora possiamo gradualmente penetrare nei piccoli mondi neutrali e concludere qualcosa. E’ la strategia perché si faccia qualcosa.
Poi la strategia ha bisogno di tattiche per essere messa in pratica. E le tattiche fondamentali nella comunicazione sono sempre le stesse: conosci il tuo target. Bisogna capire con chi si sta parlando e costruire il messaggio su questo. Altrimenti è tempo perso – in realtà è anche peggio: si ottiene l’opposto di quello che si vuole. Così, dobbiamo considerare questo, nel vasto universo del Web parliamo a tre tipi di persone integrate nei loro piccoli mondi: 1) simpatizzanti, 2) neutrali, e 3)ostili. I modi di avere a che fare con loro sono diversi.
– Parlare con persone che sono già simpatizzanti della scienza non pone problemi. Parliamo lo stesso linguaggio – ci capiamo a vicenda. Siamo un piccolo mondo, dopo tutto, anche se siamo un piccolo mondo scientifico.
– Parlare con persone neutrali è dove si può usare il consiglio che si può leggere, per esempio, in libri come “Non essere quel tipo di scienziato”. Bisogna essere competenti, bisogna essere chiari bisogna essere onesti. Se si fa questo, non c’è bisogno di seguire regole particolari nel proprio lavoro di informare le persone. Per esempio, potreste aver sentito parlare del fatto che non bisogna spaventare le persone. E’ vero, ma questo non significa che si debba addolcire talmente tanto la pillola da trasformarsi in un Ronald McDonald del clima. Il modo migliore, credo, è quello di essere onesti su quello di cui si parla e, se si vedono pericoli seri di fronte, lo si dovrebbe dire. Gran parte delle persone la fuori sono persone decenti che sono in grado di apprezzare un discorso onesto. Ci vuole tempo, bisogna essere costanti, ma alla fine funziona.
– Parlare a persone che appartengono a tribù ostili, be’, è facile: non lo si deve fare. Il nostro obbiettivo è quello di isolarli, negando loro visibilità e stiamo imparando a farlo. Per esempio Gavin Schmidt – climatologo – ha di recente rifiutato di fare un dibattito televisivo con un avversario ostile dicendo “La televisione è performance artistica, non dibattito scientifico. Non dovremmo confondere le due cose”. Ben detto! Questo, naturalmente, ha generato accuse di “codardia” contro di lui. Sicuro, sicuro… possono ululare alla luna quanto vogliono. Ma Schmidt ha capito perfettamente che sarebbe stato un errore dare a questo avversario la possibilità di apparire come se si trovasse in una condizione scientifica paritaria. E, di recente, il forum Reddit’s science ha bannato i negazionisti climatici. Vedete? Stiamo imparando a conoscere il nostro nemico! E se conosciamo il nostro nemico (e noi stessi) possiamo vincere questa battaglia.
3. Conclusione
E se ho il dono della profezia e conosco tutti i misteri e tutta la conoscenza; e se ho tutta la fede, tanta da spostare le montagne, ma non ho l’amore, non sono nulla. Paolo, Lettera ai Corinzi 13:2
La battaglia il clima si sta rivelando come la battaglia decisiva dell’umanità – se la perdiamo, perdiamo tutto. Non c’è bisogno di essere scienziati per combatterla, ma se si ha lo stato d’animo giusto è un dovere combatterla. E’ una battaglia tremendamente difficile, non non invincibile. Però, non dimenticate anche un’altra cosa: la scienza non è tutto. La ragione per cui si combatte non è solo perché si sa di essere scientificamente nel giusto. Un medico è un buon medico non solo perché conosce la scienza medica, è un buon medico perché ha cura dei propri pazienti. La stessa cosa vale per voi. State combattendo la battaglia del clima non solo perché conoscete la scienza del clima. E’ perché vi importa della vita dei vostri amici, della vostra famiglia, dei vostri bambini, dell’umanità e di tutto ciò che è vivo su questo pianeta. Questo è il solo modo di vincere.
Detto questo, mi scuso per questo mio sproloquio piuttosto lungo. Ma, se siete arrivati sin qui, spero che ci abbiate trovato qualche suggerimento utile.
… more →