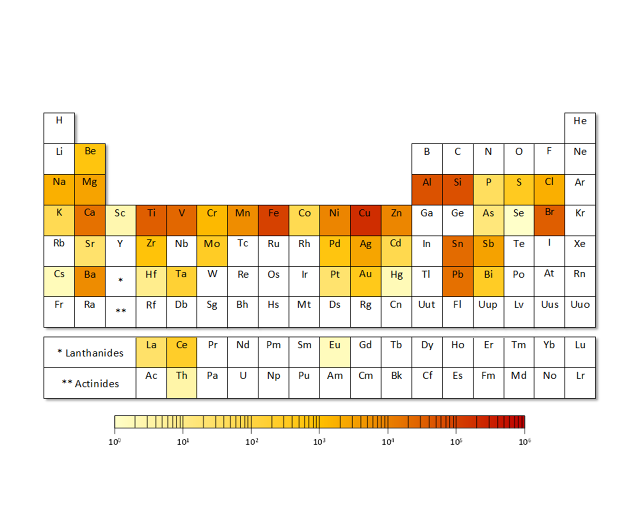Da “The Oil Crash”. Traduzione di MR
di Antonio Turiel
Cari lettori,
una delle questioni che sono state trattate in modo frammentario in questi cinque anni di post è la necessità di un cambiamento culturale profondo per fare in modo che la nostra società possa far fronte alla decrescita energetica. La maggior parte delle discussioni che ho sviluppato nel blog hanno avuto a che fare con diversi aspetti del cambio di modello economico e finanziario. Qualche giorno fa abbiamo discusso su queste stesse pagine alcuni aspetti chiave dei cambiamenti necessari nel nostro modello di assegnazione delle risorse, che alla fine è una discussione sulla struttura di fondo che deve avere un modello economico che possa funzionare quando l’energia sia meno abbondante.
Gli aspetti che ho analizzato in quel post, e ancora di più le ricette che ho proposto per ottenere strutture che possano resistere ad un processo tanto acuto come la decrescita energetica, non erano meramente economiche: alla fine dei conti, un sistema feudale in cui la maggioranza vive sulla soglia della sussistenza potrebbe ottenere facilmente gli obbiettivi di sostenibilità e resilienza per garantire la sua continuità nel tempo. Tuttavia, nella mente di tutti c’è l’interesse di preservare alcuni aspetti che abitualmente sono considerati desiderabili del modello sociale attuale (le pari opportunità, l’uguaglianza di fronte alla legge, la democrazia, l’educazione e la sanità universali, …), ben oltre il tutt’altro che ideale – a volte persino grottesco – livello in cui si trovano oggigiorno queste conquiste sociali.
Molta gente che conosce la problematica della crisi energetica da per scontato che queste strutture di carattere ugualitario siano esclusivamente frutto dell’abbondanza energetica e che senza di essa non potranno essere mantenute. Tuttavia, la grande diversità di sistemi di organizzazione sociale che si possono trovare nella Storia dell’Umanità, soprattutto se ci si allontana dalla visione prevenuta che è la norma nel mondo occidentale, indica che non è del tutto evidente che i nostri unici punti di arrivo della nostra società siano l’autoritarismo o l’estinzione.
Discutere di questi aspetti in profondità e adeguatamente richiederebbe un approccio da parte di Antropologia, Storia e Sociologia che prendessero in considerazione allo stesso tempo le crude realtà della Fisica, della Geologia e dell’Ecologia. Poche persone hanno questa capacità di sintesi. In generale sono i filosofi, come Jorge Riechmann, quelli che fanno questo sforzo di comprensione – nel senso di includere – tutto questo problema poliedrico. Ma non mi risulta che gente proveniente dalle ultime tre discipline che elencavo sopra facciano lo sforzo di avvicinarsi alle prime tre (forse fra i pochi che potrebbero farlo c’è il mio collega Antonio García-Olivares). Naturalmente io non ho le conoscenze, né il bagaglio culturale, né la capacità necessari ad affrontare con qualche garanzia questa discussione. Ma non per questo il dibattito dev’essere ignorato e capisco che nel contesto di questo blog, che pretende essere soltanto uno strumento divulgativo, sicuramente questa discussione non può essere ulteriormente posticipata.
Pertanto, enuncerò alcuni aspetti di questi valori culturali, oggi accettati comunemente in questa parte del mondo che siamo soliti chiamare occidentale, che a mio modesto modo di vedere dovranno essere rivisti in un contesto di decrescita energetica. Non potrò, per non conoscerle, proporre grandi ricette per questo cambiamento, solo qualche idea che mi sembra più o meno sensata. L’obbiettivo di questo post, pertanto, non è quello di dare una visione chiusa della questione, ma in primo luogo di mostrare un punto di vista abbastanza diverso da quello della sopravvivenza e del nichilismo in cui alcune persone, consapevoli dei gravi cambiamenti che si avvicinano, potrebbero cadere per puro sconforto e rassegnazione. E in secondo luogo aprire la discussione.
– Individualismo: Uno dei valori più fondamentali per il corretto funzionamento della nostra società attuale è l’individualismo. L’individualismo consiste nel fatto che ogni individuo cerca di ottenere i propri obbiettivi per sé stesso senza affidarsi agli altri, sì, ma è molto più di questo: è l’obbligo di ottenere quello che ci si propone, senza l’aiuto di nessuno. L’individualismo è fondamentale per il sistema economico perché l’individuo è più propenso a comprare beni per conseguire i propri fini, visto che cooperare con altri individui potrebbe richiedere di prendere in prestito ciò di cui ha bisogno o farlo congiuntamente, evitando la spesa e quindi il guadagno della fabbrica che produce ciò che gli serve. Nella cultura popolare, soprattutto attraverso la televisione e il cinema, si esaltano le qualità del capo che individualmente è capace di ottenere tutto ciò che si propone, per il suo impegno e la sua tenacia (con conseguenze non sempre positive, come abbiamo già commentato). Il lato oscuro dell’individualismo è la competizione con tutti gli altri. La cosa importante quanto il fatto che le persone contino solo sulle proprie forze (o su quelle che possono comprare) per coprire le proprie necessità, è di non ricorrere agli altri e il modo migliore di tagliare la strada della cooperazione è la competizione.
Esaltare la competizione nella cultura popolare è più difficile, poiché competere coi nostri simili, per esempio, per una pagnotta di pane ha, logicamente, un pessimo ascendente (poiché l’essere umano è, contrariamente a quanto a volte si dice, un animale eminentemente sociale). Il veicolo giusto per l’esaltazione della competitività è lo sport. Si parla di “sono spirito competitivo” e si da un’importanza smisurata allo sport (nel mio paese al calcio – così come nel mio, ndt) come veicolo culturale centrale. Una volta insegnato che avere un contesto nel quale competere è una cosa giusta, risulta più facile estendere questo argomento di competitività ad altri contesti nei quali non risulterebbe tanto ovvio. Per esempio, nelle imprese: oggigiorno danno tutti danno per scontato che le imprese “debbano essere competitive”, il che in fondo significa che competano per una nicchia nel mercato a spese di altre imprese alle quali andrà peggio e che alla fine chiuderanno. Questo è normale, ci dicono gli economisti, visto che la competitività permette di migliorare l’offerta ai consumatori e in questo modo questi usufruiscono di prodotti migliori, prodotti che, in realtà, servono ad esasperare il loro individualismo, comprando ciò che in realtà non servirebbe se chiedessero aiuto. E qui sopraggiunge un’altra delle caratteristiche culturalmente indesiderabili dell’individualismo, ma che è a sua volta necessaria, e tanto, perché il nostro sistema economico vada liscio come l’olio: l’isolamento.
Un individuo isolato si sente vuoto, incompleto, si rende conto che manca qualcosa. Non c’è niente di peggio e di più doloroso della solitudine per un animale sociale come l’uomo. Per questo l’individuo isolato, scollegato da tutto ciò che in realtà ha senso per lei/lui, anche se lei/lui non lo sa, cerca di supplire a queste carenze comprando cose coi cui riempirle. L’esasperazione di vita che genera la solitudine porta ad avere individui che consumano in modo compulsivo. Persino in molte relazioni di coppia è facile osservare che si comportano molto più spesso come singoli individui che come coppia (per esempio, se le loro attività preferite escludono l’altra/o, come darsi al calcio o andare a comprare scarpe, mentre aumentano i consumi). Per aumentare la solitudine e il consumo compulsivo, è importante incentivare la sfiducia negli altri, compresa la paura dell’altro, che porti a chiudersi, con la propria casa sempre più piena di cose è più vuota di vita. La ricetta giusta per combattere l’individualismo è cooperare con gli altri e prima ancora di fidarsi degli altri. Considerando da dove veniamo, questo non è facile, poiché nessuno si fida degli altri, addirittura ne abbiamo paura. Pensiamo che se apriamo le porte della nostra casa ad un estraneo, questo ci deruberà. Non si tratta di essere ingenui e fiduciosi, ma di credere che le cose andranno meglio se lavoriamo tutti insieme e se comprendiamo che tutti siamo utili per conseguire una transizione praticabile. Cercare colpevoli e vittime, anche se ci sono, non migliora la nostra situazione. Per costruire una relazione di fiducia, il primo passo è dare di più di ciò che ha dato l’altra/o per dimostrare la nostra buona volontà. Forse cominciare sorridendo è un passo nella giusta direzione e anche di abbassare il nostro livello di reattività e insistere un po’ fino a vedere se l’altra/o vuole a sua volta collaborare oppure no.
– Rottura del contratto intergenerazionale: I valori tradizionali che hanno sostenuto tutte le società umane di cui siamo a conoscenza si sono basati su un principio molto semplice: i padri dettavano sempre ciò che era meglio per i propri figli. In un certo senso, la vita dei padri è soggetta al benessere futuro dei suoi figli e i padri accettavano in modo naturale qualsiasi sacrificio e privazione se con questo i loro figlio avrebbero potuto stare in una posizione migliore.
Logicamente, questi padri educavano i propri figli agli stessi principi, per cui si sperava che nel momento in cui arrivavano alla loro età da matrimonio, i figli, ora padri, si comportassero nello stesso modo. Questo valore culturale, praticamente costante in tutte le società umane, ha un valore ecologico molto importante e in fondo imprime ad ogni generazione dominante una norma di autolimitazione. E’ sempre stato visto di cattivo occhio, per esempio, che un padre incosciente dilapidasse il patrimonio famigliare, o che sfruttasse i terreni che erano stati della famiglia per generazioni in modo tale che rimanessero poveri e incolti. Ad ogni generazione venivano assegnate le risorse se questa fosse semplicemente il prestanome di quella successiva, in questo modo si evitava un ritmo di consumo eccessivo che portasse all’insostenibilità: ricordiamo che la definizione più semplice e comune di sostenibilità è “gestire le risorse e produrre residui oggi in modo che i nostri figli possano fare la stessa cosa domani”. Questo modo di intendere la gestione delle risorse, questa fiducia che passa di padre in figlio, è un contratto intergenerazionale implicito molto forte o più di un contratto legale mercantile. Tuttavia, con l’irruzione del capitalismo finanziario questo contratto è saltato in aria. Visto che una delle caratteristiche del capitalismo è la necessità della crescita esponenziale, è importante rimuovere tutti gli ostacoli al consumo che evitino che si cresca al tasso esponenziale desiderato, finché è possibile, e il contratto intergenerazionale è un freno molto forte. Pertanto, è fondamentale che ogni generazione pensi a breve termine e solo a soddisfare i propri desideri ed è importante che non si senta in colpa per questo. Come sublimazione dell’individualismo spiegato nel punto precedente, il padri competono coi propri figli e sperano che la loro discendenza sia in grado di risolvere i loro problemi da soli, anche se questi hanno dimensioni ciclopiche proprio per mancanza di freno avuta dai padri. Espressioni come “tanto io questo non lo vedrò” e persino “bah’, saranno i miei figli o i miei nipoti che se ne dovranno occupare”, abituali quando si comincia a discutere di questioni ambientali o collegate alla scarsità di risorse, mostrano un atteggiamento che dal punto di vista della mentalità di solo un secolo fa sarebbe socialmente riprovevole. La ricetta giusta per combattere la rottura del contratto intergenerazionale è recuperare l’idea che il bene dei figli è la cosa più importante, che noi siamo solo di passaggio nel gestire ciò di cui godranno coloro che ci seguiranno, e recuperare il sentimento di autolimitazione che deve scaturire naturalmente quando vediamo che ciò che siamo spinti a fare contraddice gli interessi dei nostri discendenti. E’ una lotta ardua, poiché contraddice in maniera diretta molti dei messaggi pubblicitari, orientati al consumo qui ed ora.
– Perdita della percezione di un bene comune e trascendente. Molte società precedenti alla nostra sentivano di avere un fine specifico, collettivo e personale, anche se molto diverso di cultura in cultura. Poteva essere la custodia di una reliquia venerata da molte società prossime (La Mecca) o la responsabilità di dovere avere cura dal corso di un fiume (Alto Nilo) o di fare da muro di contenzione contro un nemico esterno umano (Polonia) o naturale (Paesi Bassi). A volte questo obbiettivo trascendente era piuttosto assurdo, tuttavia otteneva sempre che i membri di quella società tenessero ben presente l’obbiettivo comune e che fossero disposti a collaborare nei momenti di crisi, durante i quali l’oggetto della sua aspirazione collettiva fosse particolarmente in pericolo. A volte questo bene comune era semplicemente una scusa per mantenere unita la comunità in un obbiettivo comune, a volte la sua finalità era molto più profonda. In ogni caso, fissando un obbiettivo comune gli individui imparavano a collaborare e a cedere una parte del proprio tempo di lavoro a favore della comunità (per esempio, nello sfruttamento di terreni comuni o nella costruzione e manutenzione delle muraglie). L’esistenza di un bene comune serviva anche per razionalizzare l’altruismo, per questo non è raro trovare molti esempi nei quali si stabilisce il come, il quando e il cosa dare agli altri. Molte società hanno funzionato in questo modo per secoli, con un’evoluzione a volte curiosa degli obbiettivi considerati comuni, a volte con cambiamenti radicali. Il vantaggio di avere un bene comune identificabile è che le società pianificano il loro futuro, imponendo norme severe sulla gestione dei loro prodotti, a volte in modo molto efficiente. E l’esistenza di questo bene comune e trascendente fa sì che tutti i loro membri accettino le assegnazioni che vengono fatte. Ma col trionfo dell’individualismo, ogni senso di bene comune si perde: la società non è più una rete di mutue cooperazioni ma un insieme di individui che cercano di massimizzare la soddisfazione delle proprie necessità, anche se fosse a discapito degli altri. Qualsiasi concetto di organizzazione comune scompare, ed è importante che scompaia, perché l’homo individualis consumi sempre di più in modo che la produzione possa continuare ad aumentare esponenzialmente. Lo Stato deve intervenire il meno possibile e solo in aiuto ad una migliore espansione imprenditoriale (alla fine dei conti, come già argomentato, lo Stato è più una sublimazione dell’ideale di controllo capitalistico che uno strumento di amministrazione egualitario). La ricetta giusta per combattere la perdita del senso di bene comune è fissare alcuni obbiettivi che abbiano senso da un punto di vista razionale e moderno, al di là di motivazioni astratte o di carattere religioso. Questi obbiettivi possono essere di sostenibilità, nel senso profondo e non prostituito della parola, o quello di costruire una società resiliente in grado di adattarsi alle sfide del XX secolo o qualsiasi altro obbiettivo abbia senso per la comunità dove viene adottato. Un aspetto chiave è che questo obbiettivo comune non si aggressivo o irrispettoso dei diritti di altre comunità. Disgraziatamente, gli ideali di bene comune e trascendente che prosperano maggiormente oggigiorno hanno più a che vedere con la guerra, santa o no, che col rispetto e l’aiuto degli altri.
– Alienazione della propria responsabilità nella gestione pubblica. Il rischio fa parte della vita, c’è sempre un certo margine di incertezza sui risultati delle nostre azioni e a volte si verificano degli esiti fatali. In generale c’è la percezione che nella nostra società attuale ci sia una maggiore consapevolezza dei rischi, soprattutto per la vita, di quella che c’era per esempio un secolo fa: le misure di sicurezza sul lavoro sono incomparabilmente maggiori e molto più dettagliate, si prevedono necessità nel caso di eventi speciali e molteplici, si pianificano misure per evitare situazioni avverse, ecc. Tuttavia, nella misura in cui è aumentato il dispiegamento tecnologico, si è andata riducendo la percezione personale del rischio, fino praticamente a cancellare la responsabilità personale nella gestione del rischio personale o altrui. Oltre alla tecnologia, con la centralizzazione delle decisioni negli Stati, allontanando il centro decisionale dal luogo in cui si applicano quelle decisioni, i cittadini perdono la consapevolezza del fatto di avere qualcosa da dire sulla gestione delle cose che li toccano da vicino, fino al punto estremo di pensare che non si può fare niente per cambiare le cose. Non saliremmo mai in un autobus in cui il conduttore fosse del tutto ubriaco o mostrasse altri segni di non essere in condizioni di guidare in sicurezza, tuttavia continuiamo a delegare le decisioni fondamentali sulla nostra quotidianità a persone che non conosciamo, che vivono a centinaia di chilometri di distanza da noi e che prendono ripetutamente decisioni dannose per i nostri interessi e a favore dei grandi interessi economici. Per decenni si è accettato passivamente questo stato di cose (qualche anno fa in Spagna era diffusa una frase idiota, nel senso greco del termine: “Non me ne intendo di politica), il che semplicemente ha ingrandito i problemi coi quali ci confrontiamo ora. Anche in questo momento in cui monta una marea critica, in Spagna e in altri paesi, nei confronti del modo di procedere dei nostri responsabili politici che sembra corrotto, le alternative che si configurano aspirano alla stessa struttura di potere centrale, il centro decisionale e gestionale lontano, prevedibilmente con gli stessi problemi e risultati di quelli che ci sono ora. Le conseguenze disastrose di questo sistema di gestione così impersonale, così alienato, non si limitano alla disattenzione verso le questioni sociali, ma finiscono per mettere in pericolo la nostra stessa sopravvivenza: non può essere che consideriamo le attuali esternalità ambientali associate alla “normale attività economica” come giuste se questo porta a mettere a grave rischio la nostra stessa continuità sul pianeta (se volete vedere qualche esempio di quello che dico, leggete il post relativo). La ricetta giusta per combattere l’alienazione della propria responsabilità nella gestione pubblica è la rilocalizzazione, cosa non solo necessaria a livello di produzione ed assegnazione delle risorse, ma anche nel prendere le decisioni: i centri decisionali devono essere vicini al cittadino e questi deve impegnarsi personalmente nelle questioni che lo riguardano.
– Scelta dell’obbiettivo sbagliato nella vita. Qual è l’oggetto della nostra esistenza? Dato che resteremo per un breve lasso di tempo su questo pianeta, è importante sapere prima possibile ciò che possiamo aspettarci e quale sia l’uso migliore che possiamo fare di questo tempo stimato che abbiamo. Questa è una della grandi domande dell’Umanità dalla notte dei tempi ed ogni civiltà e società ha tentato di darle una risposta diversa, senza che si possa dire in senso stretto e nella maggior parte dei casi che gli obbiettivi che si sono posti alcune società siano chiaramente superiori a quelli di altre. La chiave è che le persone si sentano felici, realizzate nel proprio progetto di vita, per assurdo o ridicolo che questo ci possa apparire. Nella società attuale la gente è felice? E’ piuttosto discutibile. L’individualismo alienante porta ad avere un’insoddisfazione di vita che l’individuo colpito non sa da dove venga. Pensiamo, inoltre, che per ottenere la massima produttività degli individui, è stato introdotto, anche attraverso elementi culturali, una strana misura della realizzazione personale: avere successo nel lavoro. Avere successo nel lavoro significa lavorare di più, salire di grado nell’azienda, ricevere pacche sulle spalle dai capi, guadagnare più soldi e avere sempre meno ore libere. Insomma, trasformarsi sempre di più in automi (precisamente in bautomata) la cui unica funzione nella vita è produrre e consumare. E’ questo che oggigiorno viene considerato come avere successo in modo socialmente accettabile. E’ realmente ciò che vogliamo per noi stessi? E’ davvero quello che vogliamo per i nostri figli? La ricetta giusta per scegliere correttamente l’obbiettivo delle nostre vite non esiste, o perlomeno non è unica: ogni persona dovrebbe cercare la propria. La chiave è guardare dentro noi stessi e cercare di scoprire ciò che ci rende intimamente felici, quello che ci piace fare e con cosa ci piace occupare il nostro tempo. Girare completamente l’obbiettivo delle nostre vite e invece di accettare un obbiettivo unico ed uniforme per ognuno di noi, che è quello di vivere per lavorare (quelli che hanno la fortuna di avere lavoro, un bene sempre più scarso), dobbiamo invece lavorare per vivere e il tempo durante il quale non lavoriamo semplicemente vivere, facendo quello che ad ognuno di noi piace fare e che è diverso per ognuno di noi.
– L’obbiettivo delle nostre imprese. All’interno dello stesso ideale di produttività che cresce all’infinito e oltre, le nostre imprese si comportano, su una scala maggiore, come ci comportiamo noi: sono entità dirette a produrre sempre di più e a guadagnare più soldi. Ma siccome sono entità incorporee e senza mente, si comportano in un modo più automatico e più crudele. Si potrebbe dire che, se fossero esseri umani, le grandi imprese avrebbero tratti psicopatici: per conseguire i propri fini sono capaci di ingannare, corromper, estorce e persino torturare ed uccidere. Questo comportamento moralmente riprovevole è del tutto logico, alla fine dei conti, visto che un’impresa non ha i condizionamenti morali dell’essere umano: un’impresa non è un essere morale, non ha la concezione del bene e del male, solo del profitto, che è il suo fine ultimo. E’ questo ciò che vogliamo veramente? Un’impresa si deve astrarre dalla società nella quale è inscritta, essere insensibile agli effetti negativi che può causare e causa alla propria società? La ricetta giusta per scegliere correttamente l’obbiettivo delle nostre vite consiste nel delimitare chiaramente la responsabilità sociale delle imprese, cosa che si ottiene non solo con le leggi adeguate (probabilmente le leggi attuali sono già sufficienti nella maggior parte dei paesi occidentali), ma con cambiamenti più profondi. Uno, educando alle direttive: si deve fare pedagogia coi quadri direttivi delle imprese di modo che rifiutino di intraprendere misure che alla lunga danneggeranno la società di cui fanno parte e di mettere in pericolo il proprio mercato. E due, educando gli azionisti: non può essere il fine ultimo delle imprese quello di generare profitto senza sosta, sempre in crescita, cosa che prima o poi si deve rivelare impossibile in un pianeta finito e molto prima si deve rivelare dannosa per la società che non solo da loro sostentamento, ma dà senso alla loro esistenza. Investire finanziariamente in una impresa non dev’essere un mezzo per il proprio arricchimento e potrebbe anche essere che in un determinato momento potrebbe non produrre un guadagno economico, ma anche così potrebbe essere interessante se produce un beneficio sociale. Queste idee sono talmente rivoluzionarie (anche se per nulla moderne) che mi sembrano completamente impossibili da mettere in pratica, in buona misura perché si scontrano direttamente contro le basi del capitalismo, come vediamo quando analizziamo i cambiamenti del modello di assegnazione delle risorse durante la decrescita energetica.
– La nostra relazione con la Natura. Non molto tempo per gli uomini era chiaro il fatto che dipendevano dalla Natura per vivere. Anche coloro che non lavoravano la terra con le proprie mani sapevano perfettamente non solo da dove provenivano gli alimenti, ma capivano molti aspetti del delicato equilibrio che permette che la terra, l’allevamento e la pesca siano produttivi. E senza dubbio lo capivano molto meglio di molte persone al giorno d’oggi, nonostante gli anni di scolarizzazione obbligatoria, perché nessuno arrivava agli estremi di alienazione dalla Natura che si possono raggiungere in alcune città moderne. L’uomo moderno dell’urbe moderna non ha freddo, né caldo, né fame; non gli fa male la schiena per doversi chinare a raccogliere patate, né gli fanno male le braccia per manovrare una zappa; non teme per il prossimo raccolto e se vuole mangia uva in primavera ed arance in estate, anche se preferisce degustare altre delizie portate da luoghi lontani migliaia di chilometri. Non ha paura di prendersi la febbre né di morire di diarrea, quando si sente male prende la giusta pasticca e va dal medico perché gli risolva il problema che eventualmente gli si presenta, come quello che va dal meccanico a riparare la macchina. E se i problemi ambientali cominciano ad accumularsi, fino all’estremo di minacciare il suo modo di vivere, l’uomo moderno dell’urbe moderna confida che la tecnologia lo salverà, che investendo abbastanza risorgerà, perché deve essere così, invenzioni adeguate che senza effetti secondari gli forniranno ciò che desidera e lo libereranno di ciò che lo infastidisce. Tutti questi atteggiamenti sono quelli che due secoli di energia abbondante hanno forgiato nel nostro inconscio collettivo: alle spalle di una grandiosa quantità di energia ci crediamo dei giganti, ubriachi ed euforici per la straordinaria montagna di combustibili fossili su cui ci appoggiavamo. Ma man mano che il gigante dai piedi d’argilla che ci ha conquistato si scioglie, la sua forza vinta dalla Geologia e dalla termodinamica, all’improvviso ci scontriamo coi nostri limiti e non li vogliamo accettare, viziati come siamo. Uno di questi limiti è che, alla fine, anche se non lo capiamo e non lo accettiamo, noi esseri umani siamo animali come qualsiasi altro. E come tutti gli animali dipendiamo da un habitat per la nostra sussistenza, solo che nel nostro caso si tratta di un habitat molto deteriorato che mantiene un’alta funzionalità grazie all’enorme e continua iniezione di energia fossile che ora comincia a declinare. Come produrremo alimenti in modo massiccio senza trattori, mietitrici, pesticidi e fertilizzanti? Non solo: l’inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo, del mare… ci disturba e deteriora la nostra salute. E per ultimo il cambiamento climatico, una pericolosa spada di Damocle che è sempre più prossima a cadere. Le persone più consapevoli del problema sono scese in strada per rivendicare che dobbiamo prendere misure positive per “salvare il pianeta”, ma anche in queste persone si vede la nostra cecità riguardo a ciò che è la Natura: se ci estinguiamo come esseri umani, il pianeta continuerà ad esistere e continuerà anche ad esserci vita, che si adatterà alle nuove condizioni: tutte queste campagne benintenzionate si sbagliano su una questione fondamentale: non dobbiamo salvare il pianeta, che non è in pericolo. Ciò che è a rischio è il nostro habitat, il sostegno della nostra vita – è l’essere umano che non potrebbe sopravvivere se la temperatura media del pianeta sale di 6°C, il mare sale di 50 metri e i fenomeni estremi si acutizzano e si moltiplicano. Un vecchio amico, alludendo a queste questioni, diceva che un giorno gli piacerebbe sintetizzare tutte queste idee in un libro che intitolerebbe “Ambientalisti per i coglioni”; lo sfogo del titolo servirebbe fondamentalmente per chiarire che l’unica opzione che ci permette di mantenere la vita umana è adottare un atteggiamento ecologista radicale. La ricetta per recuperare una relazione sana con la Natura passa, in larga misura, per l’avvicinamento ad essa, con tranquillità e con umiltà, senza paura né arroganza. Non è una questione mistica, ma molto più prosaica: coltivare un orto, cercare funghi e asparagi selvatici in un bosco, raccogliere erbe medicinali, riconoscere i segni del cambiamento del tempo. Cose che in in determinato momento possono inoltre esserci di grande utilità. E naturalmente non maltrattarla, non alterarla al di là di quanto strettamente necessario.
– Il mito del progresso. Dall’Illustrazione, il programma del progresso è stati impiantato ed è stato spinto con decisione con la Rivoluzione Industriale. Oggigiorno, l’idea che l’unica cosa desiderabile sia il progresso e che di fatto il progresso dell’Umanità sia inevitabile, inteso come un accumulo senza fine di conoscenze e capacità tecniche che migliorano sempre la qualità di vita degli esseri umani. Tuttavia, l’osservazione dettagliata delle realtà proietta alcune ombre su questa visione così ottimista. L’umanità cammina davvero verso un paradiso terrestre? Davvero ci sono sempre più esseri umani che vivono meglio o negli ultimi anni si è constatata una contraccolpo crescente nell’opulento occidente che fino a poco tempo fa sognava questa nuova Icaria? Sono sempre convenienti i cambiamenti considerati “progressisti” oppure ci allontanano sempre di più dal vivere in un mondo migliore? Non tutti i cambiamenti implicano un miglioramento di per sé e l’idea di progresso si è prostituita a favore del progresso dell’accumulo del capitale, in una dinamica semplicemente autodistruttiva, ma il meme del progresso è culturalmente così forte che opporvisi è semplicemente un suicidio culturale. Neanche i partiti di sinistra osano dire che non sono a favore del progresso. Questo condiziona moltissimo il tipo di soluzioni che si possono immaginare per i gravi problemi energetici che ci vengono addosso, così la gente più o meno intelligente e ben collocata nelle sfere decisionali crede ciecamente che ci troviamo agli albori di una rivoluzione rinnovabile che seguirà dei percorsi piuttosto convenzionali: è solo questione di mettere più pannelli solari, più aerogeneratori, più smart grid, ecc, quando in realtà, se tale rivoluzione è possibile, non è un semplice accumulo aleatorio di sistemi ma qualcosa di molto più pianificato che implicherebbe un grande sforzo e cooperazione per poi cadere in un’economia stazionaria che implicherebbe in un modo o nell’altro il superamento del capitalismo. Il mito del progresso è così forte che nessuno osa contraddirlo e la fede cieca in esso può essere enormemente distruttiva. La ricetta giusta per superare il mito del progresso è adottare una visione molto più umile delle cose, accettando che qualsiasi soluzione proposta implica anche una serie di problemi che le sono propri e che a volte per avanzare bisogna retrocedere, specialmente in quelle cose in cui siamo andati troppo lontano. E anche che le cose non andranno necessariamente meglio da sole, ma che senza la dovuta attenzione potrebbero andare peggio, di fatto molto peggio.
– Ipermercificazione. Uno dei valori che si sono radicati nella società durante questi due secoli è che i soldi possono comprare tutto e che di fatto qualsiasi bene ha un prezzo. Inoltre, che se qualcuno vuole comprare qualcosa è giusto che qualcuno lo possa vendere. I soldi sono la misura di tutto, non solo delle relazioni umane ma che può quantificare tutto. Alla fine, tutto è in qualche modo “capitale” e quindi si parla di “capitale umano” per riferirsi ai lavoratori, di “capitale naturale” per descrivere le risorse e e di quello che gli economisti classici chiamavano “fattore terra”, Mercificare tutto ha il vantaggio che non c’è problema che non si possa risolvere portandolo nel mercato, dove avrà un compratore e un venditore. Tutte queste idee sono profondamente fasulle, come abbiamo già detto parlando della religione neoliberale, ma sono profondamente radicate, soprattutto fra la maggior parte degli economisti, che è impossibile metterle in discussione. La ricetta giusta per smetterla con l’ipermercificazione è negare che determinati beni di interesse generale, oltre a quelli collegati all’intimità delle persone, vengano mercificati, il che significa che non gli si può dare un prezzo e che pertanto si dovranno regolamentare in altro modo. Questo a molti economisti suonerà aberrante ed osceno, ma dio fatto è il modo in cui si è condotta l’Umanità per 10.000 anni di Storia e non gli è andata nemmeno troppo male (per questo è usanza che in alcuni think tank neoliberali si riscriva la Storia perché quadri con la propria narrazione, nonostante l’evidenza del contrario).
– Bisogno di valori. Una carenza della società moderna è di avere uno schema di valori morali strutturato che possano accettare tutti. Tutti percepiscono che abbiamo bisogno di nuovi valori e più universali. Da dove devono emergere? Si tratta di un anelito, come dice qualcuno, il germe di una spiritualità non cartesiana che deve superare l’eccesso di scientismo che ha caratterizzato il XX secolo? Non vado così lontano, ma credo che sia necessario approfondire la ricerca di questi valori comuni condivisi, che probabilmente non saranno esattamente gli stessi, a seconda della comunità a cui fanno riferimento, anche se probabilmente tutti condividono i punti chiave, come il rispetto per la vita umana, per i diritti degli altri e per la Natura.
*******************************************
Non per caso, tutte le questioni che ho affrontato sono più che altro questioni etiche e non semplicemente culturali. Tuttavia, è attraverso la cultura che in numerose occasioni si implementano pratiche di contenuto etico. Se il costume dice che quando muore un uomo i vicini dovranno consegnare una parte di ciò che raccolgono alla vedova fino a che il figlio maggiore non raggiunga la maggiore età, in questo costume c’è un principio di solidarietà che emana dall’ideale etico, quello della solidarietà universale. Tuttavia, questo ideale etico risponde molte volte ad un principio più prosaico che ha le sue radici in principi fisici o ecologici: una comunità in cui i suoi membri hanno cura gli uni degli altri è più resiliente, pertanto più in grado di non estinguersi in epoche di grande necessità. Il costume e i valori culturali agiscono così come un veicolo semplice per implementare le misure necessarie a garantire la continuità della comunità, tutti li imparano sin da molto piccoli e la maggioranza li accetta acriticamente perché “é costume”, “si è sempre fatto così”. Trasformare in valori culturali e in costume abitudini che migliorano la resilienza di una comunità è un modo più pratico e più efficace per far sì che si implementino realmente che non cominciare un’ardua discussione intellettuale, valutando pro e contro e discutendo tutte le alternative e le scappatoie possibili. Portati all’estremo, questi costumi potrebbero diventare sacri al punto da trasformarsi in una vera religione (come per esempio mostrava Carlos de Castro nel suo “Oracolo di Gaia”). E proprio per questo non è nemmeno una casualità che il pensiero economico attualmente dominante abbia i tratti della religione totalitaria.
Il rischio di trasformare i valori di resilienza in meme culturali o persino in dogmi religiosi è che l’ambiente variabile con cui avremo a che fare nei prossimi decenni, caratterizzati da una rapida (in termini storici) decrescita energetica e da un profondo cambiamento climatico, le ricette che funzionano oggi potrebbero essere drammaticamente sbagliate in soli pochi decenni di differenza. In questo senso, sembra preferibile provare a fare una valutazione continua della situazione, in un consiglio aperto di tutti i cittadini e con un’ampia consulenza di esperti, per avere in ogni momento la migliore strategia che vada, per una volta, a favore del bene comune. Trovare il punto di equilibrio tra pensare idee utili ed efficaci e mantenere uno spirito critico ed adattabile a cambiamenti che sono molto rapidi su scale storiche ma relativamente lenti per la psiche degli individui non sarà un compito facile e quindi non so come si possa raggiungere questo equilibrio esattamente. Alla fine di conti, non ho detto di avere la soluzione. Ciò che è chiaro è che dobbiamo approfondire queste questioni, visto quello che c’è in gioco.
Saluti.
AMT